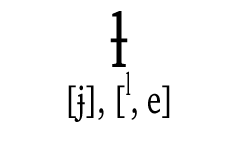
semiconsonante dorsopalatale rilassata
Si tratta di un suono tipico di alcune parlate venete, che sembra in espansione, chiamato di solito elle evanescente. Si realizza in due posizioni:
- all'inizio di parola seguito da vocale non palatale (a, o, u):
ƚate (latte it.),
ƚongo (lungo it.)
ƚuna (luna it.)
- tra vocali non palatali:
goƚa (gola it.)
góndoƚa (gondola)
paròƚa (parola it.)
svoƚàr(e) (volare it.).
Questo segno, che rappresenta un suono senza equivalente italiano (e tecnicamente definito da Giulio C. Lepschy "un'articolazione in cui l'aria passa attraverso un avvallamento nella parte centrale del dorso della lingua, sollevato verso la volta palatina, mentre i due lati del dorso della lingua sono a contatto con i lati della corona dei denti siperiori"), è stato scelto per la sua relativa semplicità nei confronti di altri fin qui adottati o proposti:
- ł, occupato però in un altro alfabeto, il polacco, con valore completamente diverso;
- 'l, col ricorso ad un segno grafico, l'apostrofo, che di solito denota un'elisione, che nel presente caso non c'è;
- l, già impiegato per un suono diverso;
- j, usato anche in alcune trascrizioni scientifiche (per esempio nell'atlante italo-svizzero nella forma y) per la somiglianza con la semiconsonante anteriore, alla quale si avvicina, ma con la quale non si identifica;
-![]() , semivocalico, che ha pure il pregio di essere molto vicino alla pronuncia reale, tanto da essere adottato, spesso nella forma semplificata e (scoea "scuola"), in scritti divulgativi e correnti;
, semivocalico, che ha pure il pregio di essere molto vicino alla pronuncia reale, tanto da essere adottato, spesso nella forma semplificata e (scoea "scuola"), in scritti divulgativi e correnti;
- ', semplice apostrofo, che qui non indica caduta completa di un suono,
Di segno contrario è la posizione dell'Anonimo da Piove che distingue anche graficamente due specie di l evanescente: una l di valore semiconsonantico e una ł molto più debole, semivocalica, che "scivola in un suono appena apprezzabile e che addirittura può sembrare soppresso": le due l evanescenti possono alternarsi anche nello stesso parlante a seconda della rapidità di pronuncia. In questa selva di pareri, sembra dover prevalere l'opportunità di non abbandonare, pur operando una distinzione grafica, il legame che lega la l alla l, da cui proviene, che è tuttora nettamente pronunciata nelle varietà periferiche della regione, e insistendo sul fatto che non va in nessun modo segnalata quando è completamente (o quasi) caduta nella pronuncia, perché assorbita da una o due contigue vocali palatali (e, i). Si trascriverà, quindi, tranquillamente agnèo "agnello", cae "calle", cassèa "cassetta", còtoe "sottane" (ma còtoƚa), fio "filo", spae "spalle" (ma spaƚa).